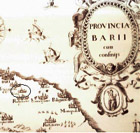|
Capitolo primo
Notizie generali e vicende particolari
Le vicende raccontate in questo capitolo sono il frutto di un tentativo di riuscire a squarciare la fitta nube di oscurità che circonda la storia di quella che sembra essere stata la più importante fabbrica, se non il più antico luogo di culto, resa più ingarbugliata e difficile da dipanare a causa dell'inesistenza di chiari documenti probatori.
Oltre alla mancanza di documentazione cartacea, manca anche ciò che hanno tutte le fabbriche per tramandarci l'evento: una data incisa su un concio di pietra disposto nel punto più idoneo, o sull'architrave della porta d'accesso, che ci ricordi sia la dedicazione della fabbrica, sia forse l'anno d'inizio della costruzione (vedi fabbrica della Madonna della Lama, 1611, dell'Immacolata, 1728 e di quella detta dei Cappuccini, 1589, quello della posa in sito della porta d'ingresso della fabbrica del Carmine, 1704, sia, per finire, una incisione lapidea interna o una piastra in bronzo sistemata nella basola d'ingresso della fabbrica con la data dell'evento realizzativo del manufatto o dell'entrata in attività ai fini del culto (come nel Santuario francescano del Beato Giacomo di Bitetto).
Per la nostra fabbrica, forse, è lecito pensare che questa mancanza sia dovuta all'esecuzione dei numerosi lavori di arretramento della facciata disposta dalle varie Sovrintendenze alle Antichità e Belle Arti succedutesi nel tempo, ultima quella di Taranto nel 1921/1926 in occasione della riparazione quasi integrale del campanile, colpito gravemente da un fulmine che danneggiò anche la facciata (vedi infra). L'arretramento, anziché essere fatto mediante l'accurata operazione di cuci e scuci dei conci di pietra (stante la loro vetustà), venne invece eseguito molto maldestramente, tanto che numerosi conci che avrebbero potuto contenere una iscrizione o anche una data andarono perduti, compresi quelli che componevano la ruota di S. Caterina (rosone).
La riprova sta nel fatto che, mentre sul lato sinistro dell'ingresso su alcuni conci interni si notano delle sillabe incise in un particolare stile, ma che, sia per essere molto lontane l'una dall'altra, sia perché non é facile collegarle compiutamente poiché alcune sono dipinte, sul lato destro dopo aver tolto l'intonaco è apparsa una icona bizantineggiante di S. Giovanni Evangelista, deturpata con colpi di piccone per far attaccare l'intonaco.
| Rimosso il fonte battesimale e l'intonaco è comparsa la parola scemo scritta a grandi lettere con colore rosso mattone indelebile. |
 |
Se, poi, si considera che solo agli inizi del 1600 sulle carte topografiche appare il toponimo Noja con il riporto grafico di un piccolo centro abitato nel quale svetta il campanile, è più che lecito, quindi, ritenere che la fabbrica abbia assunto l'attuale conformazione intornoa quell'epoca.
Tornando al problema delle fonti, le uniche disponibili, attinenti all'oggetto, sono sia i verbali redatti in latino dai cancellieri (segretari), relativi alle visite pastorali, quelli delle riunioni capitolari, alcuni atti notarili rogati in Noja tra il 1300 e il 1700, scritti anch'essi in latino, i quali, per la semantica e grafia usata, sono di difficilissima lettura e interpretazione, nonchè quanto scritto dallo storico Pasquale Pinto sul giornale locale 'Il Crivello', dallo storico Vincenzo Roppo in Noa - Memorie storiche del Comune di Noic‹ttaro, Noicattaro Fiorentino, 1927, e dal dott. Sebastiano Tagarelli nel III vol. di Chiese e monumenti (vedi infra).
Ma nessuno di questi atti fornisce particolari precisi su quando e da chi venne eretta e dedicata la fabbrica.
Ogni storico citato esterna la propria opinione, che a volte è riproposizione diversa da quanto scritto prima di lui, e di conseguenza sono contraddittorie.
Lo storico Pasquale Pinto nel numero del 1° gennaio 1925 del giornale locale "Il Crivello" con un suo articolo risponderebbe, circa le domande posteci, in maniera non del tutto completa: «Questo sacro tempio dedicato alla Gran Madre di Dio, sotto il titolo di 'S. Maria della Pace', sorse in rozzo stile romanico, verso il 1100» (sic).
Le altre notizie circa lo stile e l'arredo del manufatto sarebbero molto vicine a quelle descritte dal Garruba in Serie critiche dei Pastori Baresi (vedi infra).
Lo storico dott. Sebastiano Tagarelli, nel terzo volume Noja-Chiese e monumenti, Nuova Doge, Castellana Grotte, 1981, p. 33 e seg., citando un suo vecchio articolo pubblicato sul Bollettino della Madonna della Lama del maggio-ottobre 1973, in merito alle domande innanzi enunciate, scrive, ingarbugliando la già confusionaria e ipotetica storia della fabbrica, che la «...cappella primigenia...» [1] era sorta «..., come sappiamo, era sorta dopo la fusione delle due comunità rifugiate in Nohe da Kattry e Netion, quelle dei cristiani e la comunità dei pagani... e che a causa di ciò la si denominò di Santa Maria della Pace» (sic!). Successivamente un certo Cornelio De Vulcano, nominato primo conte di Noja niente meno che da Federico II re di Svevia, per aver partecipato alla terza crociata (indetta dall'imperatore nel 1189), l'avrebbe ampliata trasformandola in «un tempio degno della Contea».
note
1 Luogo di culto molto piccolo, al massimo di mq. 10. Dai verbali delle visite pastorali abbiamo appreso che esse erano, quasi tutte senza pavimento e senza tetto. A causa di ciò il Cappellano o Rettore veniva richiamato a provvedervi entro qualche mese, pena il versamento alla Curia di libbre di cera a seconda della gravità delle deficienze.
|