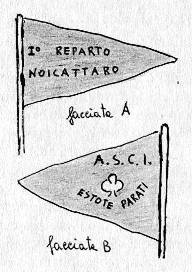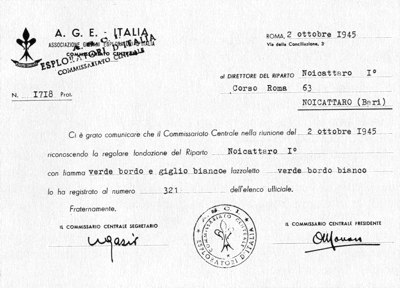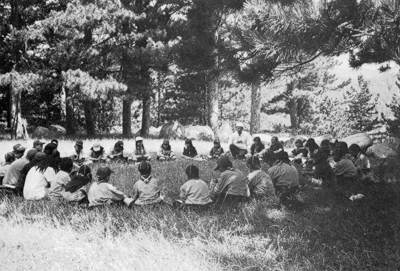|
FONDAZIONE DEL PRIMO REPARTO SCOUT CITTADINO
Dopo una serie d'incontri, proposte e consultazioni
con i relativi organi diocesani si decise di creare in Parrocchia
l'Associazione Scoutistica per dare ai ragazzi ed agli adolescenti
la possibilitą di esprimersi con gioia nella ricerca di Cristo nel
prossimo e nella natura, secondo lo spirito del fondatore dei Boy
Scouts (ragazzi esploratori) il generale inglese Sir.
Robert Baden Powell (1857 - 19941) Con l'istituzione di questo movimento
internazionale (1908), il generale Powell aveva voluto creare tra
i ragazzi una scuola di alto civismo al servizio dell'umanitą, mirando
in modo particolare alla loro educazione morale ed all'acquisizione
di una certa responsabilitą ed autonomia nelle vita libera a contatto
con la natura.
Nella nostra chiesa parrocchiale, sotto i migliori auspici di don
Servidio, mercoledģ 2 ottobre 1945 si costituģ ufficialmente il
primo Reparto A.S.C.I. (Associazione Scoutistica Cattolica Italiana)
nojano, che complessivamente formato da 35 membri, con a capo lo
stesso Arciprete nelle vesti di assistente spirituale.
A me fu data la carica di Direttore di reparto (responsabile giuridico
- morale ed organizzatore generale) ed in pił quella di Istruttore
dei Lupetti (ragazzi di etą compresa tra i 7 e gli 11 anni).
Pasquale Deflorio, che ora si trova in Germania, dove ha realizzato
il suo sogno di regista cinematografico, divenne , invece, Istruttore
(sotto l'aspetto tecnico, operativo e formativo) degli Esploratori
(ragazzi dai 12 anni in su).
I ragazzi, in tutto 32 , furono dunque divisi in due gruppi: i lupetti
e gli Esploratori, ognuno suddiviso in due squadriglie di otto elementi
ciascuna. Ogni squadriglia aveva come specifico emblema la testa
di un animale di bosco: quelle della volpe e della lepre erano rispettivamente
della prima e della seconda squadriglia Esploratori, quelle del
lupo bianco e del lupo rosso generalmente chiamate "Achela bianco"
e "Achela rosso", da cui il caratteristico grido "Aaaa --chčeee---laaaa!"
[31] , appartenevano
rispettivamente alla prima e seconda squadriglia lupetti.
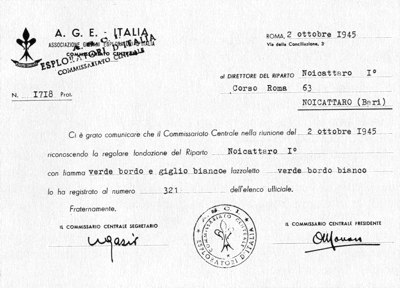 |
All'interno di ogni squadriglia venne eletto un
capo: Franceschino Ardito e Gerardo Colucci (ora religioso carmelitano
a Napoli), rispettivamente nella prima e nella seconda squadriglia
Lupetti; Pasquale Dipierro (ora a Roma, dove entrņ nell'arma dei
Carabinieri) e Nino Tagarelli di Arcangelo (ora a Genova, dove si
trasferģ come insegnante), rispettivamente nella prima e seconda
squadriglia Esploratori. Trombettiere di Reparto fu nominato Michele
Pagiarulo, chiamato famigliarmente Lalino, che faceva parte degli
Esploratori. Questi, nonostante la grave menomazione di un braccio
[32], svolgeva il suo
compito in maniera encomiabile con una rustica tromba, che aveva
costruito con l'unica mano utilizzando dei vecchi pezzi di lamiera.
La divisa
Alla confezione di ben 34 divise attesero con
notevole impegno e maestria le Giovani di A.C. e Figlie di Maria,
tra cui in modo particolare Anna e Teresa Latrofa.
Le spese per il materiale, in gran parte acquistato dalla merceria
della sig.ra Loreta Masotti sita in Via Madre Chiesa, angolo Via
S. Giuseppe, vennero sostenute completamente dall'Arciprete don
Servidio.
La divisa uguale per tutti, era costituita da una saariana color
cahi e da un paio di calzoncini e di calzettoni dello stesso colore,
che, sotto il risvolto, all'altezza delle ginocchia ma con le estremitą
pendule e visibili, recavano tre nastrini colorati, identici a quelli
cuciti sull'omero sinistro.
Uno di essi aveva il colore distintivo della squadriglia: rosso
mattone: prima squadriglia, Esploratori, grigio: seconda squadriglia
Esploratori; bianco prima squadriglia Lupetti; rosso: seconda squadriglia
Lupetti.
I rimanenti colori il bianco ed il giallo, come la bandiera papale,
significavano l'appartenenza al comune reparto.
Intorno al collo un fazzolettone verde triangolare, che scendeva
sul petto a mo' di treccia, la quale, nella parte terminale, aveva
un nodo, che poteva sciogliersi solo dopo aver compiuto una buona
azione.
Il cappello, differente nel colore e nella forma a secondo dell'appartenenza
al gruppo degli Esploratori o a quello dei Lupetti, nei primi era
di feltro e di color cachi, a falda ampia circolare e calotta a
punta, mentre nei secondi era di comune stoffa verde, simile a quello
dei fantini, con il distintivo della squadriglia applicato sulla
fascia anteriore.
L'Istruttore degli Esploratori, sulla parte sinistra del suo cappello,,
aveva un giglio fiorentino arancione. Sul mio cappello, invece,
poiché nel contempo ricoprivo la carica di Direttore del Reparto
e quella di Istruttore dei Lupetti, avevo un giglio fiorentino bicolore
verde ed arancione, di cui il primo stava a rappresentare la carica
di Dirigente generale del Reparto.
Come calzari, tutti avevamo due scarponi adatti per le escursioni
boschive.
Ogni scout, infine, venne dotato di uno zainetto personale a spalla,
di un robusto bastone lungo un metro e mezzo e di una cordicella
di tre metri agganciata, sul lato destro, alla cinghia dei calzoncini,
opportunamente predisposta al pronto uso.
Il gagliardetto
Il gagliardetto del Reparto, fissato ad un'asta,
di cole verde bandiera e a forma triangolare, recava su un lato
la scritta: I Reparto Noicąttaro; su quello opposto il simbolo
nazionale dell'Associaziine un giglio bianco fiorentino con alla
base il motto latino "Estote parati", che significa "Siate pronti"
ad intervenire, pronti a captare i bisogni e le esigenze del prossimo
ed in alto la sigla "A.S.C.I." (Associazione Scoutistica Cattolica
Italiana).
Nelle uscite ufficiali, esso era portato dall'Istruttore degli Esploratori
.
I gagliardetti delle squadriglie di ugual forma e colore a quello
del Reparto, avevano semplicemente su una faccia il proprio simbolo
animalesco ed erano portati dai capi squadriglia.
Tutti i gagliardetti vennero ricamati e confezionati dalle abili
mani della sig.na Giuseppina Parisi (1904 - 1993), con la collaborazione
di alcune giovani di Azione Cattolica.
Cronaca di una "farfallata":
la prima uscita ufficiale.
Il 28 aprile del 2946 (era la domenica successiva
alla festa di S. Giorgio - 23 aprile -Patrono dei Boy Scouts, ed
anche la prima domenica dopo Pasqua), gli Esploratori e i lupetti
fecero la loro prima uscita ufficiale in divisa. Al mattino partecipammo
tutti in chiesa Madre ad una breve cerimonia religiosa e, per conservare
il ricordo dell'avvenimento, d'accordo con l'Arciprete decidemmo
di ritrovarci il pomeriggio per una foto ricordo presso le panchine
in pietra circondate dai pini, che si trovavano a due passi dal
ponte stradale sulla Lama, in Corso Roma.[33]
Pasquale Deflorio s'impegnņ a portare la macchina fotografica, una
cassettina a fuoco fisso, e Vito Pignataro (1924 - 1992) detto farfalla,
da cui il termine "farfallata" nel titolo del presente paragrafo
si prese l'incarico di acquistare, a suo dire, per il gruppo, un
rollino fotografico in bianco e nero da otto pose. Una volta radunati
nel punto stabilito, furono consegnate le mille lire del rollino
fotografico a Pignataro, il quale con Dipierro, a turno , provvide
a scattare quelle memorabili fotografie, che avrebbero dovuto serbare
per sempre il ricordo dell'avvenimento.
Ma i fatti non andarono cosģ. Alcuni si incaricarono, all'indomani,
di portare la macchina fotografica completa di rollino a Bari, in
Via Sparano, allo studio fotografico "F.lli Antonelli" per lo sviluppo.
Vi si ripresentarono un paio di giorni dopo per il ritiro delle
foto, ma ebbero l'amarissima sorpresa di sentirsi dire dal fotografo
Antonelli che, suo malgrado, gli avevano consegnato la macchina
fotografica con un rollino privo di pellicola.
In quel momento, in preda alla rabbia per l'inattesa notizia, pensarono
subito che il Farfalla ne aveva combinato una delle sue.
Pur essendo stato ripreso per il suo comportamento scorretto, Vito
Pignataro non mosse ciglio, anzi si vantņ delle sua bravata per
aver messo tutti nel sacco, per cui si ritenne inutile avanzargli
persino la proposta della restituzione delle mille lire da lui incassate
e mai spese per l'acquisto del rollino.
Dell'accaduto, don Servidio rimase molto sconcertato e dispiaciuto,
e, a malincuore, dovette proporre l'allontanamento di Vito Pignataro
dall'Associazione per almeno un mese, rinviando ad altro momento
la decisione della sua riammissione.
Per completezza di cronaca, ritengo opportuno ricordare che, pochi
giorni prima della nostra uscita ufficiale in divisa, diversi giovani,
non condividendo il carattere confessionale, cioč espressamente
cattolico del gruppo A.S.C.I. parrocchiale, ed essendo venuti in
contrasto con i suoi dirigenti, si erano distaccati da esso per
fondarne, in contrapposizione, uno di indirizzo laico denominato
C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani), all a
cui direzione si misero Ciro Abbruzzese, Francesco Latrofa e Nino
Tagarelli.
Questo episodio, comunque, non scoraggiņ pił di tanto don Servidio.
Che non coartava mai la volontą di alcuno.
Le attivitą di Reparto
e l'addestramento.
Nella sede di Via Madonna delle grazie, il Gruppo
A:S.C.I. coabitava con il gruppo dei Giovani di A.C., con il quale
trovava dei momenti di collaborazione nell'annuale allestimento
del presepe nella stessa e nel volontario lavoro di manutenzione
del vecchio basolato della stradina di accesso.
Ma, relativamente a quest'ultimo impegno, erano particolarmente
attivi e pił esperti i giovani Esploratori, i quali, nella riparazione
delle basole rotte, adoperavano un impasto di cemento misto a polvere
di pietra, che raccoglievano dal fondo stradale inghiaiato di Via
Mola [34], nei pressi
della cappellina della Provvidenza, alla periferia del paese, lą
dove, essendo la zona notoriamente depressionaria, quella si accumulava
per effetto dl trasporto dell'acqua piovana.
Questo servizio, gratuito e altamente civile, agevolava enormemente
sia le persone anziane del rione che le donne adulte di A.. C.,
che frequentavano talvolta la sede per le loro adunanze.
Il Reparto, per i suoi meriti e la perfetta organizzazione, si meritņ
la stima di don Servidio, che volle sempre i suoi scouts al proprio
fianco in divisa nella processione del "Corpus Domini" e nel precetto
a domicilio agli ammalati come scorta d'onore al SS.mo Sacramento
e per il servizio d'ordine.
Lo spirito dell'Associazione era racchiuso tutto nella caratteristica
forma di saluto, che due membri si scambiavano al momento dell'incontro:
dopo essersi data la mano sinistra con i mignoli incrociati, ognuno
sollevava il braccio destro ad angolo retto, con l'avambraccio puntato
verticalmente al cielo; quindi, con il pollice e l'indice della
relativa mano uniti e le restanti tre dita spiegate verso l'alto,
a significare l'accettazione delle tre norme dell'A.S.C.I.[35],
pronunciava contemporaneamente, in una voce , il nome del protettore:
S. Giorgio.
Per motivi legati all'andamento climatico, l'addestramento specifico
dei giovani Esploratori a contatto diretto con la natura, secondo
il manuale dell'Associazione, avveniva nei mesi estivi e tardo primaverili,
con cadenza domenicale. Durante le vacanze scolastiche estive, anche
di giovedģ. Negli altri mesi dell'anno e, comunque, quando il tempo
non era bello, il raduno delle squadriglie, limitato alla mattinata
della domenica, avveniva presso la scuola del Carmine nell'aula
grande del maestro Angelo Didonna (1892 - 1974), alla quale si accedeva
da Via Telegrafo, dove si teneva una piccola discussione teorica,
indi si passava nell'attigua palestra interna all'aperto, per l'esercitazione
pratica.
Le escursioni campestri duravano solitamente dall'alba al tramonto
del sole, nelle domeniche in cui naturalmente si decideva di compierle.
L'appuntamento di primo mattino, gli esploratori, gią in divisa
se lo davano in chiesa Madre, dove partecipavano alla prima messa
della giornata, volgarmente detta "della campana" (alle ore 4, secondo
il calendario estivo, d'inverno, si posticipava di un'ora ).
Al termine della celebrazione, passavano dalla vicina sede di Via
Madonna delle Grazie a prendere gli oggetti personali in dotazione
(zainetto, corda e bastone) e, provvisti di cibo sufficiente preparato
in famiglia per la colazione ed il pranzo a sacco [36]
si avviavano alla spicciolata, a piedi, secondo le direttive del
loro Istruttore Pasquale Deflorio, al posto del raduno: normalmente
quello spiazzo (ora scomparso) a sinistra del ponte stradale, che
si incontra sulla provinciale per Casamassima appena fuori del paese,
costruito cura dell'Amministrazione Provinciale nel 1957.
Qui solitamente, quando di rado si decideva di non effettuare alcuna
escursione istruttiva nei dintorni, si rimaneva fino a tarda sera.
Riuniti intorno ad un piccolo falņ; altrimenti la giornata si concludeva
al tramonto del sole.
Sul posto di convegno venivano piantate delle tende, mentre i cuochi,
uno per squadriglia, si davano da fare per accendere il fuoco con
un solo fiammifero consegnato dall'Istruttore e preparare un modesto
pranzo per tutti (solo il primo piatto: generalmente pasta con sugo
di pomodoro); gli altri ascoltavano l'Istruttore, che li ammaestrava
brevemente sull'uso del bastone e della cordicella, sui vari nodi
da eseguire con questa, a secondo delle circostanze, e sul comportamento
da tenere durante le escursioni campestri.
Subito dopo, lasciato a guardia del campo un Esploratore, le due
squadriglie, separatamente, partivano per una prima battuta escursionistica.
Entrambe, seguendo piste diverse, erano tenute a lasciare dei segni
convenzionali lungo il proprio percorso, che al ritorno, doveva
essere scambiato. Ciņ per imparare a leggere i segni altrui.
Tale esercitazione era assai utile per l'orientamento in zone sconosciute
per la possibilitą di scoprire, specie lungo le lame locali, ruderi,
casette e sentieri antichi. Per le ore 12,30 - 13,00 si ritornava
alla base per consumare insieme il pranzo; quindi si ripartiva,
per altre poche ore, ad esplorare la natura circostante, che costituiva
il principale obiettivo delle varie escursioni, durante l quali
si aveva la possibilitą di raccogliere, per poi catalogarle in apposite
schede, le numerose varietą di erbe e piante selvatiche scoperte
in modo particolare sul letto delle lame, che circa cinquant'anni
fa si presentavano ancora intatte e ricoperte di vegetazione spontanea.
Era un modo per scoprire ed apprezzare la natura creata dalla bontą
divina. Con una preparazione adeguata, dovendo spesso affrontare
luoghi impervi e scoscesi [37],
furono esplorate le lame pił importanti del territorio nojano, sconfinando
nei territori di Rutigliano e di Casamassima e toccando anche i
limiti territoriali di Turi, per raggiungere i quali si percorrevano
6 - 7 km., in tal caso non si tornava pił al primo luogo di appuntamento,
ma si stabilivano tappe intermedie, senza piantare tende in alcun
posto. Il cibo si consumava lungo il percorso per guadagnare tempo.
Terminata l'escursione (intorno alla 17 - 18), le due squadriglie,
alla presenza dell'Istruttore, tenevano la propria relazione sulla
esperienza giornaliera fatta. Seguiva uno scambio di opinioni. Quindi,
fatta una preghiera comune di ringraziamento a Dio per la bella
giornata trascorsa in mezzo alla natura, si toglieva il campo e
si scioglievano le squadriglie.
Rientrando a casa, ogni Esploratore scioglieva il nodo al proprio
fazzolettone. Dio aveva gią letto e registrato quanto fatto da ognuno
di buono. L'addestramento dei Lupetti, data la minore etą dei componenti,
avveniva solo nella mattinata della domenica terminava al massimo
alle ore 12,30.
I loro genitori, infatti, ci tenevano ad averli in casa per l'ora
di pranzo.
Dopo una serie dilezioni tecniche teoriche tenute dal loro Istruttore
nella palestra della scuola del Carmine, essi venivano condotti
sui sentieri battuti dagli Esploratori per una esperienza pił diretta:
una specie di iniziazione alla vita di scouts.
Lo "Jamboree" di Bari
e la giornata "Pro seminario" di Triggiano
Nell'agosto 1946 l'intero Reparto, composto dalle
due squadriglie Lupetti e dalle due degli Esploratori, partecipņ
ad uno jamboree diocesano (raduno di scouts) che si tenne a Bari
nella villa diocesana di Via Amendola.
Qui, alla presenza dell'Arcivescovo mons. Marcello Mimmi dei dirigenti
nazionali e diocesani dell'A.S.C.I. , diede un piccolo saggio delle
esperienze acquisite, che fu molto applaudito ed apprezzato.
I Lupetti eseguirono dei giochi da manuale, mentre i giovani Esploratori
si esibirono lodevolmente nella costruzione di un ponticello sospeso
tra due grossi pini, impiegando funi e bastoni della dotazione personale.
Fu un memorabile incontro, che affratellņ tutti i Reparti A.S.C.I.
presenti della diocesi barese, offrendo l'occasione di un utilissimo,
reciproco scambio di idee e di esperienze. Peccato che, con la mia
partenza da Noicąttaro per motivi di lavoro, la nostra Associazione
scoutistica si sciolse nel 1947, dopo appena due anni di attivitą.
Qualche mese dopo lo Jamborree di Bari, nello stesso anno, la G.
M. di A.C. di Noicąttaro partecipņ a Triggiano con l'A.C. del luogo,
di cui era presidente il dott. Contesi (gią Contacessi), alla tradizionale
giornata "pro seminario", mettendo su, in collaborazione, un piccolo
spettacolo, che fu dato nel piazzale retrostante dell'ospedale provinciale
Fallacara (allora di pertinenza dell'O.N.A.R.M.O).
Esso consistette in una serie di scenette comiche e di canti, tra
i quali l'applauditissima barcarola Santo di Mira, eseguita dal
gruppo nojano, che fu accompagnato alla fisarmonica dal nostro Esploratore
Nicola Masotti [38].
Allo spettacolo era presente l'arcivescovo di Bari, mons Mimmi.
A conclusione del programma, su mio invito, Michele Pagliarulo,
del gruppo Esploratori [39],
prese un cappello da esploratore e attese che il suo Direttore,
cioč il sottoscritto dicesse ai presenti: "Signori, questa č la
sorpresa, cui avevo accennato all'inizio, ideata dai Giovani Esploratori
di Noicąttaro. Adesso girerą tra voi con un cappello l'Esploratore
Michele Pagliarulo, perché ognuno possa fare spontaneamente la sua
piccola offerta per il seminario".
L'Arcivescovo diede per primo l'esempio, facendo la sua offerta.
Fu raccolta una discreta somma e, come ringraziamento, gli Esploratori
nojani concessero al generoso pubblico la replica del canto Santo
di Mira.
La gradita visita degli
Esploratori a don Peppino a Torre a Mare.
Una domenica di primavera del 1946, prima di Pasqua,
quando il gruppo era ancor compatto e non era ancora avvenuta la
prima uscita ufficiale in divisa, visto il bel tempo, gli Esploratori
decisero di trascorrere la giornata al mare. Intanto avevano avvertito
don Peppino Ardito che avrebbero partecipato nella sua parrocchia
di Torre a Mare [40]
alla Messa delle ore 10, animandola con il canto gregoriano. Avevamo
stabilito, di comune accordo, di raggiungere Torre a Mare attraverso
i sentieri costeggianti le lame, che non fossero, perņ, strade principali,
si fissņ la partenza da Noicąttaro intorno alle ore 4 del mattino.
La Masseria di Macario (contrada agricola S. Vincenzo), scelta come
prima tappa intermedia e quindi definita come "Campo n.1", doveva
essere raggiunta da entrambe le squadrilgie, che avena preferito
seguire itinerari diversi, l'una a destra e l'altra a sinistra del
greto del torrente Giotta (o Giotti)
[41], entro le ore 8.
Insieme all'Istruttore Deflorio, io seguii, invece, proprio il letto
del trorrente, su cui dappertutto spuntavano erbette e fiori d'ogni
specie, che sembravano lodare Dio con il loro profumo e la loro
bellezza, rendendo indescrivibile la gioia di questo nostro contatto
diretto con la natura.
L'aria del primo mattino, fresca e impregnata dell'odore della resina
degli alberi e dell'erba della pietraia, tra la natura selvaggia
e incontaminata, giovava ai nostri polmoni. Ad un tratto vedemmo
scappare a gran velocitą davanti ai nostri piedi una coppia di lepri.
Nelle vicinanze, nascosta in una sterpaglia, c'era una nidiata di
piccoli, che accarezzammo teneramente prima di proseguire.
Quando tutti ebbero raggiunto la Masseria Macario ciascuna squadriglia
descrisse all'Istruttore il percorso seguito ed i vari segni lasciati
nei posti ritenuti pił interessanti e noti. Di qui ci spostammo
sulla provinciale n.57, la "Noicąttaro - Torre a Mare", all'epoca
non ancora asfaltata e impolverata, per raggiungere, non pił separatamente,
la meta prevista alla partenza: Torre a Mare.
Durante il tragitto ci imbattemmo in numerosi piccoli rettili, come
vipere, serpi nere e cervoni, tipici delle nostre zone, che di volta
in volta offrirono all'Istruttore lo spunto per spiegare agli stessi
come comportarsi, specialmente con le vipere.
A Torre a Mare, nella nuova "Piazza Abba Garima" (localitą Fontana
nuova), stabilimmo il "Campo n.2", fissando nel terreno il gagliardetto
di Reparto. Come sede operativa, per la preparazione del pranzo
da parte degli addetti, fu presa la casa di mia madre, sita nell'ambito
della Piazza.
Alle ore 10 in punto fummo tutti nella chiesa di S. Nicola per la
Messa, che don Peppino Ardito, attendendoci con grande entusiasmo,
si apprestava a celebrare. Il nostro Esploratore Nicola Masotti
si sedette dietro l'armonium per accompagnare i canti. Durante l'omelia,
don Peppino colse l'occasione per ringraziare i suoi giovani compaesani
della loro visita, aggiungendo, con una nota di nostalgia ed insieme
di compiacimento, che la madrepatria Noja - Noicąttaro, nonostante
la recente separazione territoriale, non si era dimenticata dei
fratelli di Torrepelosa [42].
Infine, rivolto a tutti i presenti, con gli occhi socchiusi e con
tono altamente profetico, esplose con questo auspicio: "io sono
ardito come il mio cognome, cosģ com'č inciso nel marmo sito sulla
parete in fondo alla chiesa [43],
per cui con tutto l'ardore che sento nel cuore rivolgo a Dio l'accorato
appello mi conceda la grazia di assaporare la gioia del ritorno
alla madrepatria, territorio che fu dei nostri antenati".
Al termine della Messa ci salutammo calorosamente con lui e facemmo
ritorno al "Campo n.2", dal quale ci spostammo poi nella sede operativa
per la consumazione del pranzo, alla cui preparazione aveva preso
parte l'amico conosciuto col soprannome di "Céime d cąole". I pasti
furono consumati in allegria, né mancarono episodi divertenti, come
quello che vide Franco Latrofa, Ciro Abbruzzese ed i soliti bricconi
di gruppo assalire letteralmente l'albero dei fioroni, ornamento
dell'attiguo giardino della casa, per coglierne i frutti pił o meno
maturi. Terminato il pranzo, ci fu un po' di tempo libero per tutti
fino al tramonto.
Quando si udģ il richiamo dell'adunata del nostro validissimo trombettiere
Pagliarulo, ci riunimmo tutti attorno al gagliardetto elevata a
Dio una comune preghiera di ringraziamento, si riprese la via del
ritorno seguendo i margini della strada provinciale.
|
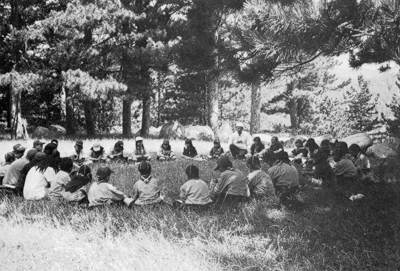
Nella foto
l'Autore partecipa alla riunione di un gruppo di scouts cosentino
nel bosco del villaggio Palumbo (sila Piccola)
|
Note
[31]
Probabilmente dal greco "achilykos:
lupo terribile
[32] Aveva
perduto l'arto in un incidente occorsogli nell'officina di riparazione
auto della ditta Guarini - G.M. Pannarale e D. Pesce (locali Divella,
oggi Stangarone, su Corso Roma) Ogni possibile complicazione fu
scongiurata dal tempestivo intervento del prof. dott. D. Divella.
[33] Le
panchine erano state installate da poco dal Comune di Noicąttaro
in seguito all'ampliamento di Corso Roma, in prossimitą del ponte
stradale operato dall'Amministrazione provinciale. All'epoca, la
provinciale per Bari iniziava dall'Osso: cosģ in gergo nojano il
limite comunale disegnato con basole in pietra di traverso sulla
strada, ora scomparso sotto l'asfalto, che congiungeva l'attuale
imbocco di Via Vecchia Casamassima con il marciapiede antistante
l'abitazione di Gioacchino Gambatesa, civico 93, in Corso Roma.
[34] All'epoca
(intorno agli anni'940), le principali Vie d'uscita da Noicąttaro
erano ricoperte di vricc, cioč di ghiaia, che il continuo passaggio
dei traini e dei carri ippotrainati frantumava fino a ridurla in
polvere biancastra, la cosidetta "polvere della via nuova", che
i nostri contadini usavano nel trattamento degli ulivi.
[35] Le
tre regole fondamentali dell'Associazione erano la Responsbilitą,
la Vita libera a contatto con la natura e la Bontą.
[36] Immancabili tra gli
altri semplici alimenti, pane e frittata fichi secchi farciti di
mandorle (i ghiakčune).
[37] Una delle esercitazioni
pił importanti consisteva nell'attraversamento in senso trasversale
del letto della lama, aggrappandosi con mani e piedi ad una robusta
corda tesa tra due alberi di opposta sponda.
[38] I
giovani erano stati preparati da Mimģ Ciavarella, gią rientrato
a casa a guerra finita.
[39]
I giovani Scouts erano in gran parte iscritti nelle liste di A.C.,
cosģ come io stesso ricoprivo nel contempo la carica di Presidente
di A.C. e di Direttore del Reparto A.S.C.I.
[40] D. Peppino, originario
di Noicąttaro (vi era nato nel 1877), fu il primo parroco della
parrocchia di S. Nicola in Noicąttaro sita nella sua borgata di
Torre Pelosa, che a seguito di aggregazione di essa a Bari divenne
Torre a Mare, dove morģ nel 1970.
[41]
Per poter imboccare la cosiddetta Lama Giotta, bisognava prendere
dal paese la strada vicinale S. Vincenzo e attraversare la Lama
dell'Angelo
[42] Torrepelosa,
per un ignobile quanto mai ingiusto decreto reale voluto dai fascisti,
nel 1934 veniva strappata a Noicąttaro ed annessa a Bari. Quattro
anni dopo, gli stessi amministratori baresi ne chiesero ed ottennero
dal Governo di Roma anche la mutazione dell'antico toponimo in quello
attuale di Torre a Mare.
[43] Don Peppino si riferiva
alla lapide commemorativa, tuttora esistente, dell'inaugurazione
dell'attuale chiesa parrocchiale (19 settembre1940), in calce alla
quale, in qualitą di Parroco, č inciso il suo Cognome.
|