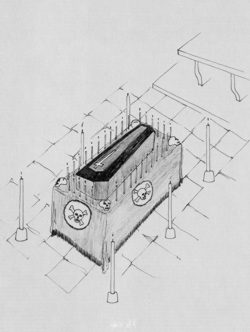|
NOVEMBRE: L'OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Ben poco è rimasto oggi delle antiche usanze. Allora
si era più semplici devoti verso i cari defunti, mentre oggi si
è terribilmente condizionati dalla smania di gareggiare per dimostrare
la propria agiatezza rispetto agli altri nel costruire i cosidetti
gentilizi.
E già, noi non potevamo pensare a far costruire un manufatto di
classe per contenere i resti mortali dei nostri cari eravamo poveri
(non di Fede, però).
La poesia "A livella" di Antonio de Curtis, alias Totò, non deve
essere mai dimenticata, se vogliamo veramente l'affratellamento.
Il rituale della commemorazione dei defunti, a quel tempo, iniziava
con una processione serale, che si svolgeva l'ultimo giorno di ottobre.
Tutto il Clero locale, con la partecipazione della confraternita
della Madonna della Lama, si riuniva nella chiesa dell'Immacolata.
Di qui, mentre le campane della chiesa Madre scandivano i rintocchi
specifici della circostanza, cosa che a me, piccolo ignorante, provocava
molta emozione, il sacro corteo si muoveva per fare il giro del
paese, raccogliendo offerte da destinare alla celebrazione di Sante
Messe in suffragio di tutti i defunti del paese, in particolare
di quelli periti durante l calamità pestilenziale del 1816. Contemporaneamente
prendevano a girare per il paese (locali pubblici: bar, circoli
associativi ecc.) alcuni confratelli della Madonna della Lama col
cappuccio bianco sul viso, i quali avevano nella mano sinistra un
teschio di legno (come salvadanaio) per la raccolta delle offerte
e nella mano destra un campanello per il richiamo. Non saprei proprio
immaginare quale reazione o emozione proverebbero le nuove generazioni
al suono di quei mesti rintocchi.
Di tutto ciò non è rimasta alcuna traccia, come anche di quanto
mi accingo a raccontare in merito. In chiesa Madre veniva allestito
un catafalco (vedi disegno) quasi al centro della navata centrale,
circondato da numerose candele di tutte le grandezze.
Per otto giorni al mattino, dopo la messa, e la sera, dopo la recita
comunitaria del Santo Rosario in suffragio dei defunti, si svolgeva
una funzione specifica.
L'organista, il maestro Nicola Laudadio (1869 - 1952) [16],
cantava il Libera me Domine. Il Sacerdote, indossati cotta e piviale,
e, assistito da un luigino, che in una mano teneva il secchiello
dell'acqua santa con l'aspersorio e nell'altra reggeva il turibolo
e la navetta contenente l'incenso, si portava presso il catafalco
(si trattava di una semplice impalcatura di legno coperta da un
drappo nero, su cui era sistemata simbolicamente un bara vuota)
allestito in mezzo al corridoio principale della navata principale.
Quando l'organista terminava il canto gregoriano del Libera me Domine,
egli leggeva il rituale Oremus e intonava il canto gregoriano del
Pater noster e, mentre quello continuava questo canto, incensava
il catafalco e lo aspergeva con l'acqua santa.
A questo punto Ciccio il sacrestano, o chi per lui, provvedeva a
suonare le campane a "martello" (a morto). A conclusione di questo
cerimoniale, mentre il Sacerdote officiante e il luigino guadagnavano
processionalmente la sacrestia, l'organista intonava il canto finale
de': La Pace dei Santi…., che era eseguito dall'assemblea dei fedeli
visibilmente commossa.
Nella chiesa della Madonna delle Lama, l'ottavario dei defunti veniva
celebrato in maniera più ampia. Il catafalco era di dimensioni maggiori
e addobbato con panni neri d'occasione. Le candele, a centinaia,
erano sistemate tutt'intorno e sopra il catafalco ; ai quattro angoli
venivano messi quattro teschi di legno per le offerte.
La funzione assumeva un tono devozionale particolare in quanto si
svolgeva di primissimo mattino, ma il cerimoniale era identico a
quello della chiesa Madre.
Il giorno della Commemorazione dei defunti, poi, nell'ossario del
cimitero cittadino veniva celebrata da don Vito Sisto la messa per
tutti i defunti del paese.
Il becchino Francesco Cappelli (1877 - 1951) fungeva da chierichetto.
La popolazione partecipava numerosa, anche se l'ora era molto scomoda:
alla "campana", cioè alla 5 del mattino. Le Autorità civili andavano
al cimitero in corteo nel pomeriggio per deporre nel sacrario dei
caduti in guerra una corona di alloro.
All'epoca il detto manufatto era sito al centro dei quattro scomparti
del cimitero. Dal primo novembre e per una settimana intera, Via
Garibaldi (ora Corso Roma) era molto battuta per il via vai di cittadini
che si recavano al camposanto a deporre sulla tomba dei loro congiunti
una foto degli stessi, un cerotto e possibilmente qualche fiore
di produzione propria. La foto serviva ai parenti del sepolto per
individuare il posto ove era tumulato il proprio caro.
Giovanni Climaco e i figli di Rocco Sorino (il "mutilato") facevano
la spola tra il ponte sulla lama ed il cimitero con un canestro
pieno di cerottini tenuto sul basso petto e agganciato al collo
con uno spago e gridavano: "Cerotti che bei cerotti".
In ogni casa, la sera del primo novembre, le mamme, prima di andare
a dormire, preparavano il tavolo da pranzo con una tovaglietta bianca
di bucato, un bicchiere d'acqua, una lampada ad olio e della frutta
fresca e secca.
Le nonne ci raccontavano che in quella notte tutti i cari defunti
in ispirito, venivano processionalmente in paese.
Ognuno entrava nella propria abitazione, si sedeva a tavola, mangiava
(simbolicamente) quello che voleva. Indi tornava insieme agli altri,
sempre in processione, al luogo di partenza. Idiozie? Comunque quelle
idiozie, per qualche giorno, servivano a mantenerci reciprocamente
un po' più buoni.
A tanto contribuivano, anche, dei suonatori di fisarmoniche del
tempo (organetti), i quali andavano in giro per il paese a questuare,
suonando e cantando il Dies irae.
Costoro precedevano gli zampognari, che arrivano non molto tempo
dopo a rammentarci l'avvicinarsi di un avvenimento più grande: il
Santo Natale. Cose d'altri tempi?
Infatti, tutte queste cose sono ritenute lontanissime, come le stelle
del cielo, dalle nostre preoccupazioni giornaliere.
È opportuno, però, che per un solo minuto, durante la nostra vita,
ci si fermi a riflettere sul contenuto della cennata lirica di Totò
con una buona dose di coraggio.
Per il vero cattolico, la buona dose di coraggio è nelle prole finali
del sigillo della propria Fede: il Credo, e nelle parole del Salterio
della messa dei defunti: "Vita mutatur, non tollitur" (La vita non
è tolta, ma trasformata).
[16] Il
maestro N. Laudadio, esperto suonatore d'organo, avviava al canto
gregoriano gli scolari della V^ elementare, con Il Pange lingua,
era il canto liturgico cui teneva molto.
|